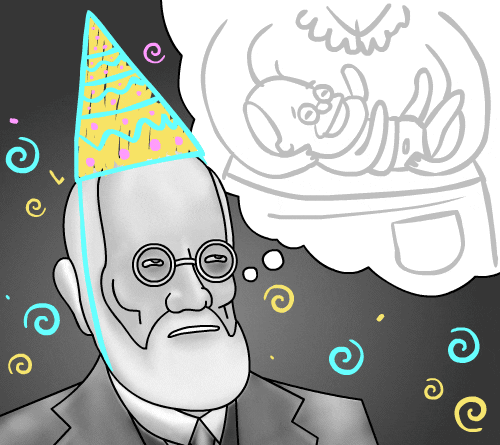Io vorrei affrontare il tema dell’anoressia partendo da due angolazioni un po’ particolari: una che riguarda la questione del posto, il posto del soggetto anoressico, e l’altro che attiene ad un certo tipo di approccio terapeutico, un metodo multidisciplinare che è in voga molto in questa fase di attualità e di moda della diagnosi della malattia dell’anoressia.
La questione del posto: mi interrogavo su quale sia per il soggetto anoressico il posto nella rappresentazione edipica e mi veniva in mente la metafora del posto a tavola, quando noi decidiamo di sederci ad un tavolo, che sia come questo posto da cui parlo a qualcuno o come il vostro, che siete lì ad ascoltare o anche ad una tavola imbandita.
È molto importante per ciascuno di noi trovare il proprio posto, anche quando abbiamo libertà di valutazione: non è mai casuale la scelta di un posto, dipende dal contesto, una cena, dove, con chi, le persone che decidono di sedersi accanto a noi, spesso e volentieri si aspetta che gli altri prendano posto per poi fare la nostra scelta, oppure i posti strategici che ci possono essere in situazioni in cui la presenza di ciascuno assume un ruolo significativo.
Il soggetto anoressico che posto ha a tavola?
Solitamente prepara, ed anche bene, il cibo per i commensali, però non si siede mai a tavola: è dappertutto ma non è in nessun posto. Non sembra voler occupare una posizione ben precisa, perché probabilmente le vorrebbe occupare tutte.
Nella metafora edipica, il posto non è più rispettato dal soggetto (anoressico), non è più accettato, non è più gradito, sembra non voler occupare un posto e, anche quando sembra esserci il desiderio di voler occupare il posto dell’altro, anche lì il soggetto è senza posto, proprio perché occupa il posto di un altro.
In modo particolare, la regressione corporea che il soggetto anoressico acquisisce con la riduzione di peso lo rende in qualche modo inappetibile sul piano fisico, lo rende inappetibile e quindi in qualche modo poco desiderabile, non desiderabile dagli altri.
Nella metafora edipica, nei confronti di chi poi l’anoressica può desiderare di non essere desiderabile? Nei confronti della figura paterna.
Se ne parla poco, nel campo dell’anoressia, della figura paterna, perché solitamente è liquidata come una figura assente, marginale, poco significativa nei confronti del soggetto che soffre di questa patologia.
Però c’è da chiedersi: se fosse, nella rappresentazione dell’anoressica, nella realtà psichica del soggetto, veramente assente questo padre, che bisogno ci sarebbe di evitarlo e di fare in modo di non essere desiderato da lui?
Molto brevemente vi riporto il caso di una mia paziente di diversi anni fa, una ragazza di 26-27 anni che mi ha raccontato che quando compì i sette anni, festeggiava l’anniversario in casa propria con tutti gli amici di scuola e, mentre giocava con loro, venne chiamata in disparte dal padre sulla porta di casa, che, con due valigie in mano, le comunicava che stava abbandonando la famiglia.
Un padre da lì in poi fisicamente assente, ma terribilmente presente per un soggetto del genere. Proviamo ad immaginare che tipo di fantasma questa persona poi si porterà dietro: anche se non ne parlerà mai sarà sempre molto presente con il suo tradimento.
Tra l’altro questa paziente è un’educatrice di infanzia, che nel lavoro ha pessimi rapporti con i collaboratori e gli altri colleghi professionisti e, di contro, un ottimo rapporto, privilegiato, con i bambini e i loro genitori, al punto tale che spesso e volentieri va a trovare, nel pomeriggio, a turno, alcuni bambini con i quali ha tessuto un particolare rapporto, per giocarci insieme, lei con il bambino, come se fossero coetanei, in una sorta di simbiosi.
Ritornando un attimo alla figura paterna, c’è stato e c’è tuttora un tentativo di rivedere e di rivalutare la figura paterna in relazione al tema dell’anoressia; però la tendenza comune è un po’ quella di apprezzare il padre e la sua presenza in ambito familiare come alternativa, se non addirittura sostituto, della figura materna.
Negli anni Ottanta, negli Stati Uniti, sono state messe in commercio delle protesi: una pancia di gomma, quindi finta, con una cintura che il futuro babbo avrebbe dovuto indossare per provare il brivido della gravidanza e quindi poi prepararsi al parto della moglie, oppure delle mammelle, anch’esse finte, da applicare con un reggiseno, una delle quali collegata con un tubicino ad un biberon ed il babbo doveva offrire questa mammella finta al figliolo, nella funzione di un allattamento dal punto di vista paterno.
Quindi, provate ad immaginare la distorsione che si struttura anche rispetto alle teorizzazioni intorno a certi temi.
Ritornando alla questione del posto, si potrebbe dire, in un certo senso, che il soggetto anoressico è portato ad autorizzarsi ad essere in un posto che non si trova da nessuna parte, quasi in una sorta di autarchia.
Solitamente, come dicevo prima, il posto è quel qualcosa che viene occupato e viene sancito anche dagli altri; un posto con un intendimento unilaterale è un posto che acquisisce qualcosa di assoluto, perché non è in relazione; in assenza di relazione con l’altro non è possibile collocarsi e quando non è possibile collocarsi ci si sposta verso l’idealizzazione e nell’idealizzazione, in quanto tale, c’è l’impossibilità della realizzazione.
Si strutturano così dei problemi a livello di identità.
Sempre questa stessa persona mi riportava un sogno in cui partoriva, ma partoriva un bambino a pezzi: prima la testa, poi il tronco, le braccia, le gambe, come se fossero delle parti di una bambola. Una volta concluso il parto, prendeva questo puzzle, questo insieme di pezzi, lo metteva in una scatola e chiudeva il tutto, archiviava il tutto.
Nelle situazioni un pò più felici, meno critiche, i meccanismi di difesa portano a far sì che il soggetto si concentri di più su una parte specifica del proprio corpo, che diventa così, in qualche modo, il capro espiatorio di tutte le problematiche fisiche; non si parla più come una volta di esercizi spirituali, ma si parla di esercizi fisici, fitness e cose simili e, attraverso la messa a fuoco su una parte del corpo si ritrova l’equilibrio.
Quando poi si fa un intervento chirurgico per correggere questa parte che, seppur marginale nell’immagine d’insieme del soggetto, viene vissuta come deturpante ed orribile, c’è dopo, solitamente, un’operazione di spostamento e si va a trattare un’altra parte del corpo che non piace, si ritorna cioè a questo puzzle che non si sa gestire nel suo insieme.
E, se quando si fa un certo tipo di intervento terapeutico, sul piano psicologico, che porta all’asportazione “psicochirurgica” di quella parte, l’equilibrio che il soggetto aveva comunque tentato di mantenere fino a quel momento viene disastrato, e la persona crolla.
Quindi, i vari tentativi terapeutici di soddisfare le richieste di queste persone portano, nello sforzo di eliminare il sintomo, a destabilizzare, piuttosto che ad aiutare il soggetto nel suo vero problema, semplicemente cercando di avvicinarsi a ciò che, nella richiesta, il soggetto non otterrà mai, perché anche se gli viene offerta “la soluzione”, non sarà mai sufficiente e soddisfacente.
Purtroppo i problemi legati agli eccessi dell’anima sono ormai diventati malattia, sono diventati quel qualcosa che è di competenza esclusiva della medicina, un fatto medico.
Si parla di anoressia come malattia, come sindrome; mentre noi siamo abituati a vedere il sintomo anoressico come tale, non esiste un’anoressia, esistono persone che manifestano un proprio personale disagio attraverso un sintomo che può avere sì degli aspetti a comune con altre persone, ma che non può essere trattato attraverso protocolli terapeutici.
Nelle procedure terapeutiche multidisciplinari c’è un ulteriore aggravamento di questa frammentazione del soggetto.
Immaginate delle persone che vengono istituzionalizzate, solitamente c’è un’equipe medica che si occupa di loro sul piano medico, quindi terapie alimentari complementari, flebo per intenderci oltre alla tradizionale terapia psicofarmacologica per tamponare i sintomi psichiatrici associati; poi c’è l’equipe degli psichiatri, degli psicologi, degli psicoterapeuti, a secondo di come sono organizzati, che agiscono in contemporanea su questi soggetti, per cui la persona viene sbalestrata da una situazione di gruppi e di incontri di autoaiuto, oppure di una terapia psicologica individuale o collettiva, verso contesti immediatamente successivi, in cui, nell’arco di pochi minuti viene forzato a ciò che non vuole, ad esempio ad un’alimentazione parenterale con una flebo, nello stesso ambiente.
Qual è il posto che potrebbe occupare questa persona? Non ce l’ha, è dappertutto ma non è in nessun posto.
La multidisciplinarietà dell’intervento, che oggi è molto in voga, continua a considerare la malattia come tale, come sindrome, non come problema specifico ed individuale di quel soggetto, e con un tipo di procedura che sia il più possibile vicino a protocolli, che devono valere, in linea di massima, un po’ per tutti: possono variare la posologia o alcune modalità di somministrazione, ma nel suo complesso l’intervento, il protocollo, è di questo tipo.
D’altro canto, come dicevo prima, gli eccessi dell’anima non sono più una questione umana ed il vuoto dell’anima non si può riempire più con il solo cibo, ci vuole ben altro.
Come osservava Kafka: “Scrivere una ricetta è facile, ma ascoltare la sofferenza delle persone è molto, ma molto più difficile”.